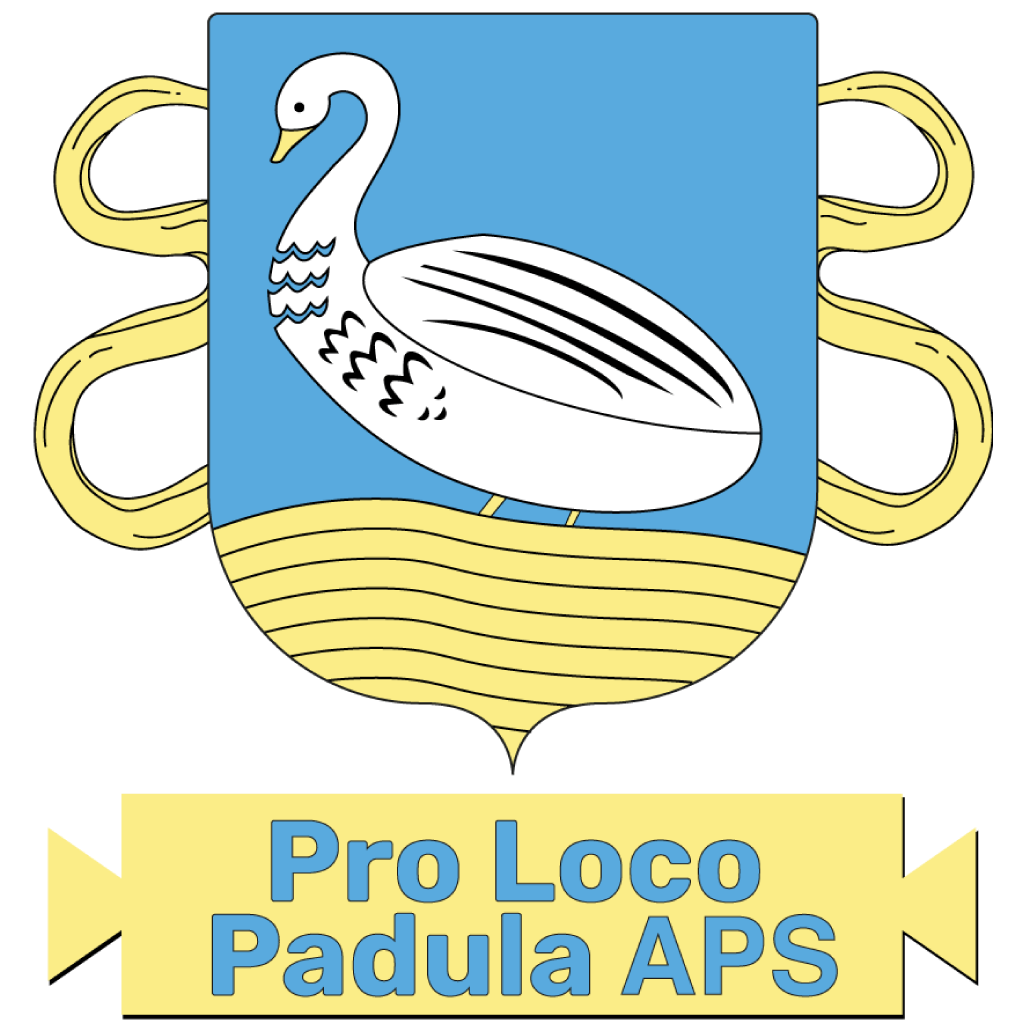La Reggia del silenzio
Riconosciuta patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1998, la Certosa di San Lorenzo è il monumento simbolo della città di Padula.
Fondata nel 1306 e poi ampliata tra il Seicento e il Settecento, la Certosa incarna la grandezza del barocco campano. La sua architettura è un labirinto di meraviglie: dal monumentale chiostro grande, il più vasto al mondo, con le sue 60 colonne, alla maestosa scalinata ellittica che conduce alla biblioteca. Ogni angolo racconta la vita dei monaci certosini, tra la solitudine delle loro celle e l'opulenza delle sale comuni.
Visitare la Certosa di Padula significa immergersi in un'atmosfera di pace e grandezza, dove il silenzio delle antiche mura dialoga con la ricchezza degli affreschi e la complessità degli spazi. È un'esperienza che unisce la bellezza artistica alla profonda spiritualità, lasciando un segno indelebile in chiunque la attraversi.
Visite guidate
Orari di apertura
9:00 - 19:00
*Verifica orari e giorni nelle aperture straordinarie
Giorni di apertura
Martedì chiuso.
Lunedì - Domenica
Indirizzo
I luoghi della certosa
Il Chiostro
È noto per essere uno dei chiostri più grandi del mondo, con una superficie di circa 12.000 metri quadrati. Le sue dimensioni colossali, con una lunghezza di 149 metri e una larghezza di 104 metri, incantano per la loro simmetria e l'armonia delle forme. La struttura, in stile tardo-manierista, è caratterizzata da un portico con 84 colonne che circonda un'area centrale con una fontana. Lungo i suoi tre bracci si aprono le celle dei monaci, spazi di preghiera, studio e meditazione, riflettendo il ruolo fondamentale del chiostro nella vita certosina. Al piano superiore, una loggia con affreschi offre un percorso elevato per la passeggiata settimanale dei padri. Il Chiostro Grande è un esempio straordinario di architettura barocca e un luogo carico di storia e spiritualità, che testimonia la grandezza e la ricchezza della Certosa di Padula nel corso dei secoli.

Lo Scalone
Lo scalone collega i due livelli del complesso monastico, in particolare unisce il Chiostro Grande alla biblioteca, un luogo di sapere e studio. Era la "salita sapienziale" che i monaci potevano percorrere, con il permesso del Priore, per accedere ai preziosi volumi custoditi nella biblioteca. Di "scuola vanvitellania", è nna scenografica scala elicoidale che si innalza all'interno di un corpo di fabbrica ottagonale. La sua forma a spirale, senza sostegni centrali visibili, crea un effetto visivo di grande leggerezza e dinamismo.
L'intera struttura è realizzata in pietra, e ciò che la rende unica sono i suoi trentotto gradini monolitici. Ognuno di questi gradini è scolpito da un unico blocco di pietra e si apre a ventaglio, sorretto unicamente da un cordolo in pietra che funge da elemento portante.

La Biblioteca
La biblioteca era un luogo fondamentale per i monaci, che, provenienti spesso da ambienti socialmente e culturalmente elevati, davano grande importanza allo studio. Un'iscrizione sul magnifico portale in marmo recita "Da sapienti occasionem et addetur ei sapientia" (Dai al sapiente l'occasione e la sua sapienza aumenterà), a sottolineare la vocazione del luogo. Originariamente conteneva circa 20.000 volumi, ma a seguito delle spoliazioni avvenute dopo la soppressione del convento, gran parte del patrimonio è andata perduta o è stata trasferita, con alcuni volumi oggi conservati presso la Biblioteca Nazionale di Napoli. Sulla sommità di alcune scaffalature, inoltre, è presente la scritta "Libri prohibiti", indicando la presenza di testi di alchimia, astrologia e diritto il cui studio era limitato.
La sala è un vasto ambiente riccamente decorato, con elementi in stile barocco e settecentesco. In particolare, il soffitto presenta tele di pregio, come quelle realizzate da Leonardo Olivieri nel 1763, che raffigurano allegorie dell'Aurora, del Giudizio Universale e della Sapienza. Il pavimento, di notevole valore, è un'opera in maiolica risalente al Settecento, attribuita alla bottega dei Massa.

Il Parco
Gli spazi verdi della Certosa di Padula non sono semplici giardini decorativi, ma parte di un sistema funzionale e spirituale, essenziale per la vita quotidiana dei monaci, un perfetto equilibrio tra architettura, natura e spiritualità.
Oltre ai giardini privati, una vasta area esterna della Certosa era destinata a orti e campi coltivati, dove i monaci e i conversi producevano ciò che era necessario per il loro sostentamento. Nonostante gran parte di queste aree sia oggi tornata a una natura più selvaggia, la loro presenza testimonia l'autosufficienza e la profonda connessione della comunità con la terra.

© Copyright 2025 Pro Loco Padula APS - created by Praticoweb - Privacy e Note Legali